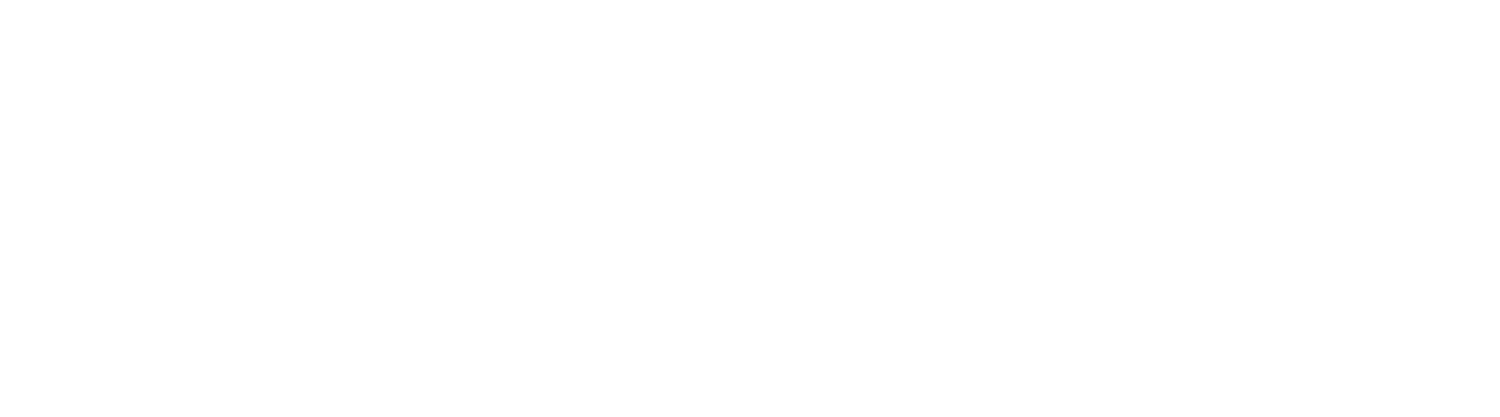Indice
Il sistema giuridico italiano riserva particolare attenzione alla tutela della funzione pubblica, che si esplica attraverso l’attività di coloro che sono incaricati di esercitare potestà e funzioni pubbliche per conto dello Stato. La protezione giuridica di queste figure si manifesta principalmente attraverso una serie di norme penali che mirano a salvaguardare l’autorità e l’ordine pubblico, garantendo a chi ricopre incarichi pubblici la possibilità di adempiere ai propri compiti senza subire interferenze illecite o atti di violenza.
In questo contesto, i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale, disciplinati rispettivamente dagli artt. 336 e 337 c.p., rappresentano due delle fattispecie criminose più rilevanti per la tutela della pubblica amministrazione. A tal punto che ad entrambe non può essere applicata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis, co. 3 n. 2, c.p., quando le condotte sono poste in essere nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziario o pubblica sicurezza. L’art. 336 c.p. punisce chiunque usi violenza o minaccia per costringere un pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto del proprio ufficio, ovvero contrario ai propri doveri. L’art. 337 c.p., invece, sanziona chi si oppone con violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, mentre questi compie un atto del proprio ufficio o servizio.
Questi due reati, seppur distinti nella loro struttura e nelle condotte incriminate, condividono la stessa ratio: proteggere l’esercizio delle funzioni pubbliche da qualsiasi interferenza violenta, coercitiva o intimidatoria. La loro previsione è essenziale non solo per salvaguardare l’autorità del singolo pubblico ufficiale, ma anche per preservare il corretto funzionamento della macchina amministrativa e, in definitiva, il principio di legalità che regge l’ordinamento.
VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE
Ai fini di un’analisi consapevole del delitto in questione non si può prescindere dalla lettura dell’art. 336 c.p. secondo il quale :
“chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario a i propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.”
Tradizionalmente si ritiene che il bene giuridico tutelato dalla norma, come anche affermato in precedenza, sia da rinvenire nel buon andamento della P.A. e quindi nella libera formazione della volontà delle pubbliche amministrazioni. Invero taluni in dottrina, considerano questo reato come plurioffensivo nella misura in cui è volto alla tutela anche della libertà di determinazione della persona fisica che esercita le funzioni o il servizio e della sua incolumità.
Come si evince dalla lettura della norma, il soggetto attivo può essere chiunque mentre il soggetto passivo viene individuato dal legislatore tanto nel pubblico ufficiale quanto nell’incaricato di pubblico servizio, le cui definizioni ai fini della legge penale sono indicate rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p..
Per quanto invece attiene alla condotta penalmente rilevante, l’art. 336 c.p. prevede due diverse fattispecie di reato:
- La prima (I comma) punisce chi usa violenza o minaccia per costringere i soggetti passivi di cui sopra a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio.
- La seconda (II comma) punisce chi tiene la stessa condotta ma al fine di costringere il p.u. o l’ i.p.s. a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o comunque per influire su di lui.
Si noti come tale bipartizione riprenda chiaramente quella analoga prevista dal legislatore agli artt. 318 e 319 c.p. tra corruzione impropria e propria.
Ad ogni modo, la coartazione della volontà del soggetto passivo deve avvenire con violenza o minaccia.
- Per minaccia si intende la prospettazione di un male futuro e ingiusto consistente nella lesione o messa in pericolo di beni giuridici del soggetto passivo o di altre persone a lui collegate in virtù di rapporti di parentela, affetto etc.. La minaccia deve inoltre essere idonea a sortire un effetto di costrizione nel soggetto passivo. Tale idoneità, secondo la giurisprudenza, deve essere valutata ex ante ed in concreto. Ciò significa che per vagliare la sussistenza della necessaria offensività della minaccia ai fini dell’integrazione del reato occorre verificare, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto al momento dell’azione, se concretamente la stessa fosse idonea a turbare il soggetto passivo nello svolgimento delle sue funzioni. ( Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7 aprile 2014 n. 32705)
- Per violenza, invece, secondo la tesi tradizionale, si intende l’uso di un’energia fisica che arrechi pregiudizio fisico al soggetto passivo, determinandone una costrizione della volontà.
Con riferimento all’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo specifico. Quindi, oltre alla consapevolezza e volontà di usare violenza o minaccia, oltre alla consapevolezza e volontà di rivolgere tale condotta contro un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per l’integrazione del reato è necessario che l’agente si sia rappresentato e abbia voluto anche il fine ultimo di costringere la vittima a compiere un atto del suo ufficio o contrario ai propri doveri o ancora ad omettere un atto dell’ufficio.
RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE
La seconda fattispecie di reato che abbiamo menzionato in apertura è la resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.. La norma prevede che:
“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto dell’ufficio o di un servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”
Il delitto in questione, come si può agilmente notare dalla lettura della norma, presenta marcate somiglianze con quello analizzato pocanzi.
Il bene giuridico tutelato risulta essere sostanzialmente coincidente con quello del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Si può dunque individuare tanto nel buon andamento della P.A. quanto nella libertà di azione dei pubblici funzionari.
Il soggetto attivo può essere chiunque, mentre il soggetto passivo si individua anche in tale caso nel pubblico ufficiale e nell’incaricato di pubblico servizio. Occorre precisare che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, secondo un recente adagio della Suprema Corte, “sono considerati in servizio permanente, non cessando dalla loro qualifica pur se liberi dal servizio, posto che anche in tali circostanze, sono tenuti a esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge.” (Cass. Pen., Sez. V, sent. 20 luglio 2022, n. 35691). Pertanto una condotta di resistenza nei confronti di un ufficiale o agente di P.G., anche fuori dal servizio, ma che eserciti le proprie funzioni può integrare il delitto di cui all’art. 337 c.p..
Orbene, considerato quanto già analizzato supra in merito alla violenza e minaccia, con riferimento alla condotta penalmente rilevante, possiamo individuare 3 ipotesi di resistenza, di cui l’ultima non ha rilevanza penale:
- La resistenza attiva propria, ossia quell’atto violento o minatorio di opposizione indirizzato direttamente sulla persona del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto d’ufficio o di servizio.
- La resistenza impropria, ossia quell’azione avente le caratteristiche richieste dal reato in questione, non indirizzata direttamente nei confronti del pubblico ufficiale ma comunque idonea ad impedirne od ostacolarne l’azione.
- La resistenza meramente passiva, la quale si ha quando un soggetto si limita a non collaborare o ad assumere un atteggiamento di inerzia nei confronti del pubblico ufficiale, senza però compiere atti di violenza o minaccia attiva. In altre parole si tratta di un comportamento che ostacola indirettamente l’operato dell’autorità, ma senza azioni fisiche volte ad opporsi attivamente all’atto del pubblico ufficiale. Si pensi al manifestante che si siede a terra e si rifiuta di spostarsi quando gli viene ordinato di liberare una strada dalla polizia. Solo questo tipo di resistenza non integra il reato di cui all’art. 337 c.p.
Anche per il reato di cui all’art. 337 c.p., come per il delitto ex art. 336 c.p., l’elemento soggettivo richiesto da legislatore assume i connotati del dolo specifico.
Infine preme segnalare un contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite nel 2018. La questione riguardava l’ipotesi di violenza o minaccia, costituenti la condotta di resistenza, indirizzate nei confronti di più pubblici ufficiali. Ci si domandava quindi se in questo caso si fosse difronte ad un singolo reato o ad una pluralità di reati.
Secondo un primo orientamento, laddove la funzione pubblica sia svolta da più pubblici ufficiali le azioni dei quali si integrano vicendevolmente, la pluralità delle reazioni con cui il soggetto agente le vuole bloccare assume le forme del reato continuato ex art. 81 c.p.. Coloro che sostenevano tale tesi valorizzavano la plurioffensività del reato di resistenza, il quale non tutela solamente il buon funzionamento della pubblica funzione unitariamente intesa, bensì anche la libertà di azione e svolgimento delle funzioni di ciascun pubblico ufficiale (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 25 maggio 2017, n. 35227).
Il secondo orientamento invece riteneva di considerare tali ipotesi come espressione di un reato unitario in quanto avvenuto nel medesimo contesto fattuale per opporsi al compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, anche quando la violenza o la minaccia sono indirizzate nei confronti di più pubblici ufficiali. Detta tesi veniva sostenuta sempre valorizzando l’elemento del bene giuridico tutelato dalla norma. In questa diversa visione però, lo stesso veniva individuato primariamente nel buon andamento della P.A. e solo marginalmente nell’offesa al pubblico ufficiale, che quindi non era ritenuta meritevole di tutela piena. (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 14 dicembre 2016, n. 4123).
Sul punto come affermato sopra, si sono espresse le Sezioni Unite che hanno aderito al primo orientamento, ossia quello della sussistenza di una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione (Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n. 40981).
LE AGGRAVANTI SPECIALI
L’art. 339, co. 1, c.p. prevede una serie di aggravanti speciali comuni sia al reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. sia a quello di resistenza ex art. 337 c.p. In particolare, si tratta di aggravanti ad efficacia comune che quindi importano un aumento della pena fino ad 1/3 quando la violenza o la minaccia sono commesse alternativamente:
- nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- con armi;
- da persona travisata;
- da più persone riunite;
- con scritto anonimo;
- in modo simbolico;
- valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.
L’art. 339, co. 2 e 3, c.p. prevede invece delle circostanze aggravanti indipendenti in virtù delle quali la pena va dai 3 agli 8 anni di reclusione con riferimento agli artt. 336 co. 1 e 337 c.p. e dai 2 agli 8 anni di reclusione con riferimento all’art. 336, co. 2 c.p. quando la violenza o la minaccia sono commesse:
- da più di 5 persone riunite, mediante l’uso di armi anche soltanto da parte di una di esse;
- da più di 10 persone riunite, anche senza l’uso di armi;
- mediante lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
LA DIFFERENZA TRA IL REATO DI RESISTENZA E QUELLO DI VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE
Stante la quasi completa sovrapposizione delle fattispecie di resistenza e di violenza a pubblico ufficiale in ragione del medesimo atteggiarsi della condotta penalmente rilevante consistente sempre nell’esplicazione di una violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale, la giurisprudenza ha elaborato un criterio di distinzione tra le due norme di tipo temporale.
Ed infatti dalla lettura di entrambe le fattispecie di reato non sembra troppo complesso ricavare il seguente criterio distintivo.
Si configura il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. quando la condotta violenta o minatoria precede il compimento dell’atto da parte del p.u..
Si configura invece il reato di resistenza ex art. 337 c.p. quando la condotta violenta o minatoria viene posta in essere durante il compimento dell’atto da parte del p.u. al fine di impedirlo.
GLI ATTI ARBITRARI DEI PUBBLICI UFFICIALI. QUANDO LA REAZIONI DEL PRIVATO è LEGITTIMA
La resistenza opposta ad un pubblico ufficiale non sempre viene considerata reato dall’ordinamento. Vi sono infatti dei casi in cui le condotte che abbiamo avuto modo di analizzare in precedenza, sono consentite dalla legge.
L’art. 393 bis c.p. prevede che:
“non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342, e 353 c.p., quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto dagli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.”
In primo luogo, occorre osservare che la natura giuridica di questa norma non è affatto chiara. La stessa è stata rubricata come causa di non punibilità, taluni la riconducono alle cause di esclusione della colpevolezza, ma la giurisprudenza ormai dominante la considera una causa di giustificazione.
Ad ogni modo l’art. 393 bis c.p. scrimina tanto la reazione materiale quanto quella verbale del cittadino contro un atto arbitrario della P.A..
Secondo l’orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza ai fini della sussistenza dell’esimente suddetta è necessario vi sia un nesso di causalità tra la resistenza del privato e l’atto arbitrario del p.u.. In altre parole è necessario un vero e proprio rapporto di consequenzialità, proporzionalità ed attualità tra l’azione e la reazione.
La giurisprudenza inoltre descrive l’arbitrarietà di un atto del pubblico ufficiale come una prevaricazione fine a se stessa, espressione di gratuita prepotenza e di autentico arbitrio, e caratterizzata dalla consapevolezza del p.u. in ordine all’arbitrarietà della propria azione (Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 29 ottobre 2015, n. 19758).