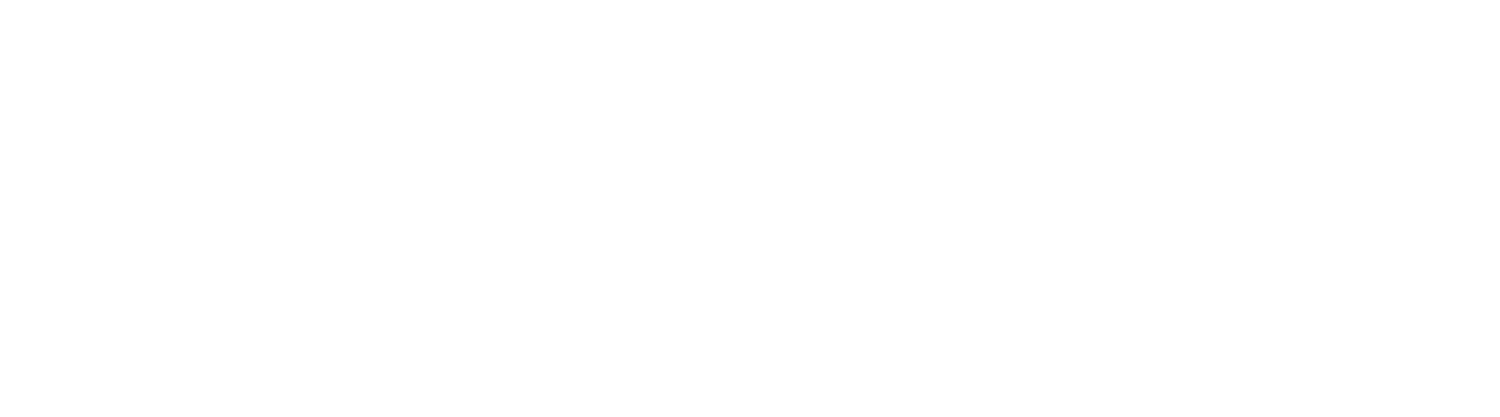Indice
Il delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina è previsto dall’art. 571 c.p., il quale stabilisce che:
“Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.”
IL BENE GIURIDICO TUTELATO
Originariamente, avendo il legislatore del 1930 collocato questa fattispecie di reato nel titolo XI del II libro del codice penale, ossia il titolo dedicato ai delitti contro la famiglia, si individuava come bene giuridico tutelato dalla norma proprio la famiglia, in ragione del particolare ruolo che era riconosciuto alla stessa all’interno della società dal pensiero fascista all’epoca dominante.
Successivamente però l’interpretazione del bene giuridico protetto dall’art. 571 c.p. è mutata. Ciò è dovuto primariamente ad una lettura più attenta della fattispecie di reato, la quale prevede una condotta aggressiva che si indirizza non solo contro l’istituzione famigliare ma anche contro altri rapporti, quali quelli di istruzione, cura, educazione, vigilanza o custodia ovvero quelli relativi all’esercizio di una professione o di un’arte.
Da tale considerazione si è ricavata la portata plurioffensiva del reato in esame. La norma quindi tutela non solo la stabilità e armoniosità dei rapporti interni alla famiglia ma anche e più precisamente l’incolumità psicofisica del soggetto passivo, l’inviolabilità della libertà personale, il diritto alla manifestazione del pensiero, il diritto all’autodeterminazione e alla tranquillità psichica.
I SOGGETTI DEL REATO
Nonostante in apertura la norma faccia riferimento a chiunque, il soggetto attivo del reato non può essere chiunque.
L’art. 571 c.p., infatti, è un reato proprio, che può essere integrato solo da coloro i quali sono legati al soggetto passivo da un rapporto qualificato che gli consente di esercitare sullo stesso una qualche forma di autorità.
LA CONDOTTA TIPICA
La condotta tipica del reato di cui all’art. 571 c.p. consiste nell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina.
La prima considerazione che discende da tale affermazione è che se viene punito l’abuso significa che vi è un uso lecito dei mezzi di correzione o di disciplina, consentito quindi dall’ordinamento.
L’uso dei poteri disciplinari o correttivi per essere lecito, deve in primo luogo essere previsto dall’ordinamento giuridico in capo al soggetto attivo. In altre parole il predetto deve essere titolare dello ius corrigendi in forza di una norma giuridica.
In secondo luogo l’uso dei poteri legittimamente riconosciuti in capo ad un soggetto, per essere lecito, non deve mai tracimare in violenza fisica o psichica o comunque essere impiegato per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle per le quali l’ordinamento lo consente.
Gli esempi più comuni di abuso di mezzi di correzione o di disciplina si verificano spesso in ambito scolastico, dove insegnanti ed educatori nell’esercitare il loro ius corrigendi sui minori oltrepassano i limiti stabiliti dall’ordinamento.
Proprio in relazione a tale casistica la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata, contribuendo a delineare maggiormente i confini e i tratti essenziali di questa fattispecie di reato.
Si riportano di seguito alcuni esempi di massime giurisprudenziali sugli elementi costitutivi della condotta penalmente rilevante:
Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 11795/2013: “il concetto di abuso, per cui è sufficiente il dolo generico, presuppone in ambito scolastico un potere educativo o disciplinare che deve però essere usato per le finalità ad esso proprie, senza travalicare i limiti previsti dall’ordinamento, ed avuto specifico riguardo alla evoluzione interpretativa del paradigma di “abuso minore”, pacificamente esteso non solo alle condotte dannose sul piano fisico, ma anche a quelle pregiudizievoli sul piano psicologico, correlato allo sviluppo anche sociale della persona, destinataria dell’azione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia”
Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 15149/2014: “integra la fattispecie criminosa in questione l’uso di un mezzo, vuoi di natura fisica, psicologica o morale, che abbia come effetto l’umiliazione del soggetto passivo, posto che l’intento educativo va esercitato in coerenza con una evoluzione non traumatica della personalità del soggetto cui è rivolto; con la precisazione che con riguardo ai bambini il termine correzione, presente nella dizione normativa, va inteso come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo”
Per quanto riguarda poi l’utilizzo della violenza a fini correttivi o educativi, secondo la giurisprudenza di legittimità, tali condotte non possono mai integrare il reato di cui all’art. 571 c.p..
Afferma infatti la Suprema Corte che “esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da “animus corrigendi”, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo – che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore – lì dove l’abuso ex art. 571 cod. pen. presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti. (Fattispecie in cui la Corte, riqualificato nel reato di percosse il comportamento dell’insegnante che aveva spinto la testa dell’alunno nel lavandino, ha annullato la condanna per difetto di querela)” (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 13145/2022).
Infine occorre segnalare che il reato in oggetto non ha natura abituale e ben può essere integrato da un solo atto espressivo dell’abuso, la cui ripetizione può integrare semmai altri reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione. (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 18289/2010).
LA NATURA GIURIDICA DEL PERICOLO DI UNA MALATTIA
Come si evince dalla lettura del testo della norma, il reato risulta punibile solo se dalla condotta abusiva posta in essere dal soggetto agente derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.
Per malattia deve intendersi una qualsivoglia conseguenza che vada a coinvolgere la salute psichica del soggetto passivo (stati d’ansia, insonnia, inappetenza, depressione, disturbi del comportamento).
Inoltre è opinione diffusa in giurisprudenza che la dimostrazione del pericolo della malattia nella mente possa anche essere desunta dalla natura stessa dell’abuso o secondo le regole della comune esperienza, senza particolari perizie medico-legali, ogniqualvolta la condotta dell’agente sia, ictu oculi, astrattamente suscettibile di produrre tali conseguenze.
Ciò detto, risulta essenziale comprendere quale sia la natura giuridica del pericolo di una malattia. Sul punto si sono affermate due tesi.
- La prima tesi ritiene che il pericolo di una malattia sia una condizione obiettiva di punibilità.
Secondo tale impostazione quindi si applicherebbe l’art. 44 c.p., in ragione del quale il reato si consuma nel momento in cui viene posto in essere l’abuso e diventa punibile quando sorga il pericolo della malattia, pericolo che, in punto di elemento soggettivo, non è oggetto del dolo né va provato il nesso di causalità con la condotta abusiva. Detto orientamento è sostenuto da coloro che ritengono che il pericolo della malattia non integri il disvalore del reato e non sia quindi un elemento essenziale dello stesso.
- La seconda tesi ritiene che il pericolo di una malattia sia l’evento del reato. Da tale qualificazione discende che ai fini dell’integrazione del reato occorre provare il nesso di causalità tra la condotta abusiva e il pericolo della malattia. Quest’ultimo deve inoltre essere oggetto di rappresentazione da parte dell’agente.
L’ELEMENTO SOGGETTIVO
In punto di colpevolezza, ai fini dell’integrazione del reato è necessario che il soggetto agente sia in dolo. Il dolo richiesto è generico, può pertanto assumere la forma di dolo eventuale. Deve quindi rappresentarsi e volere tutti gli elementi della fattispecie di reato, compreso il pericolo di una malattia se lo si ritiene evento, escluso se lo si ritiene condizione obiettiva di punibilità.
IL SECONDO COMMA: CIRCOSTANZA AGGRAVANTE O FATTISPECIE AUTONOMA
Il secondo comma dell’art. 571 c.p. prevede una pena più grave rispetto al primo nel caso in cui si verifichi l’evento lesivo (malattia) o l’evento morte in capo al soggetto passivo.
Nel primo caso si applicano le pene previste per le lesioni semplici ( da 6 mesi a 3 anni di reclusione) o per le lesioni aggravate ( da 3 a 7 anni se grave o da 6 a 12 anni se gravissima) ridotte di 1/3.
Nel secondo caso (morte) si applica la reclusone da 3 a 8 anni.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria tale disposizione è una circostanza aggravante del primo comma, quindi eventualmente bilanciabile con altre circostanze attenuanti. (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 34492/2012)
Secondo una tesi minoritaria si tratterebbe invece di una fattispecie autonoma di reato.
LA DIFFERENZA CON IL REATO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI
Per molto tempo il criterio distintivo fra le due fattispecie in oggetto, ossia il reato previsto dall’art. 571 c.p. e quello disciplinato dall’art. 572 c.p., si rinveniva nell’elemento soggettivo.
Si sosteneva infatti che la struttura dell’art. 571 c.p., che prevedeva una condotta consistente nell’esercizio dello ius corrigendi implicava la natura specifica del dolo richiesto per l’integrazione dell’elemento soggettivo del reato. In altre parole si ricavava la necessaria finalizzazione della condotta verso intenti educativi o correttivi.
Pertanto si sosteneva che laddove non fosse stata ravvisabile tale finalità, sussistendone gli ulteriori presupposti, si sarebbe configurato il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.
In realtà questa impostazione è stata ormai abbandonata. Ed infatti la differenza tra le due fattispecie non sta tanto nella connotazione soggettiva e psicologica che deve avere la condotta quanto nella natura oggettiva della stessa.
Detto altrimenti, quando il mezzo impiegato è lecito e previsto dall’ordinamento in capo al soggetto agente, ma lo stesso ne abusa si applica l’art. 571 c.p., quando invece la condotta si sostanzia nell’uso di mezzi illeciti che l’ordinamento non riconosce in capo all’agente allora si applicherà l’art. 572 c.p.