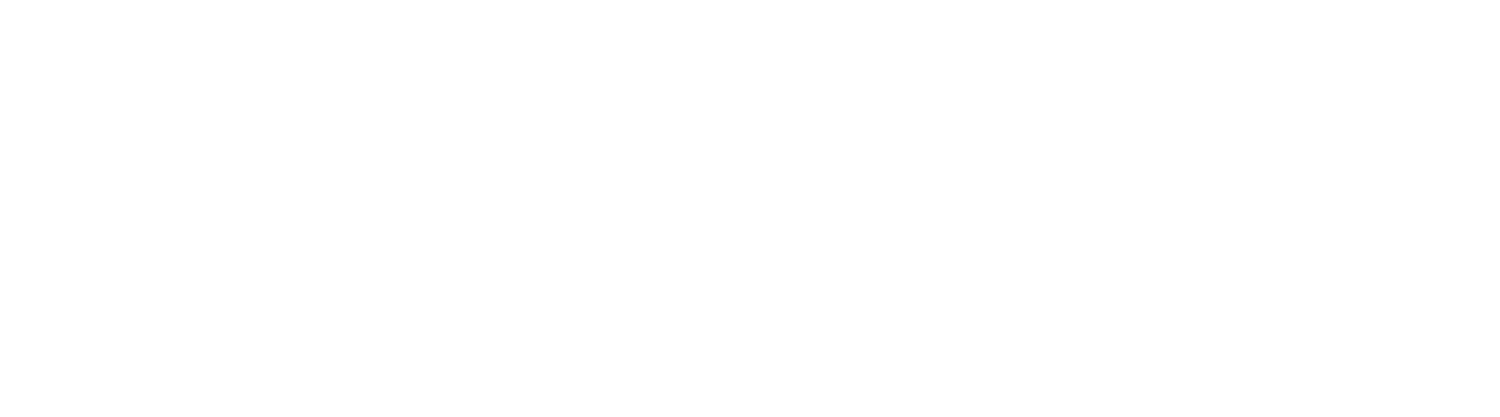Indice
PREMESSA
Il termine bancarotta trova la sua origine in un’usanza medievale secondo cui il mercante che risultava debitore insolvente, oltre ad essere destinatario di diverse sanzioni, subiva la rottura in pubblico del banco su cui solitamente esponeva la merce.
Oggi come allora, mutatis mutandis, i delitti di bancarotta rappresentano i reati cardine dell’intera normativa penal-fallimentare.
Con essi si puniscono quei fatti, posti in essere dall’imprenditore o da soggetti che ricoprono una posizione qualificata all’interno della società, che determinano un pregiudizio degli interessi dei creditori dell’impresa.
La disciplina attuale si rinviene negli artt. 322 e ss. del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) che dal 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore) ha sostituito la previgente disciplina degli artt. 216 e ss. R.D. 267/1942 (Legge fallimentare).
In primo luogo occorre evidenziare che vi sono diverse forme di bancarotta e per ciascuna di esse la dottrina ha elaborato i seguenti macro criteri distintivi:
- Classificazione in relazione al soggetto attivo:
Bancarotta propria: si tratta delle ipotesi previste dagli artt. 322 (fraudolenta) e 323 (semplice) CCII, in cui il soggetto attivo è l’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale.
Bancarotta impropria: si tratta delle ipotesi previste dagli artt. 329 e 330 CCII, in cui il soggetto attivo è individuato negli amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società in liquidazione giudiziale.
- Classificazione in relazione all’elemento psicologico:
Bancarotta fraudolenta: ipotesi previste dagli artt. 322 e 329 CCII, punite esclusivamente titolo di dolo.
Bancarotta semplice: ipotesi previste dagli artt. 323 e 330 CCII, punite anche a titolo di colpa.
- Classificazione in relazione alla collocazione temporale del fatto commesso:
La bancarotta pre-fallimentare punisce le ipotesi in cui i fatti vengono posti in essere prima della sentenza di fallimento (art. 322, co. 1, CCII), la quale assume natura giuridica di condizione obiettiva di punibilità;
La bancarotta post-fallimentare punisce invece i fatti posti in essere dopo la sentenza di fallimento (art. 322, co. 2, CCII), la quale, in tale ipotesi, si presenta come presupposto della condotta.
LE DIVERSE IPOTESI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA PROPRIA
Come anticipato supra, il delitto di bancarotta fraudolenta propria è previsto e punito dall’art. 322 CCII. Al suo interno si possono distinguere 3 diverse ipotesi di reato: la bancarotta patrimoniale, la bancarotta documentale e la bancarotta preferenziale.
- Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 322, co. 1, lett. a), CCII) punisce “con la reclusione da 3 a 10 anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti.”
Dalla disposizione legislativa testé citata si ricava agilmente una duplice ipotesi di reato, ossia quella di riduzione dell’attivo patrimoniale punita a titolo di dolo generico nonché quella di fraudolenta simulazione del passivo per la cui integrazione si richiede invece il dolo specifico.
- Il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 322, co.1, lett. b), CCII) punisce sempre con la reclusione da 3 a 10 anni l’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale che “ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profittoo di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.”
Anche con riferimento a questa seconda ipotesi di reato, dalla lettura della norma si distinguono due diverse tipologie di condotta tra loro alternative. La prima consistente nella sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili per cui è richiesto il dolo specifico, ossia lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare un pregiudizio ai creditori, alla seconda invece si riconduce tanto l’omessa tenuta delle scritture contabili quanto la tenuta delle stesse in guisa da impedire la ricostruzione della situazione dell’impresa.
- Il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 322, co. 3, CCII), a differenza delle precedenti ipotesi, punisce “con la reclusione da 1 a 5 anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.”
Quest’ultima ipotesi di reato si pone come obbiettivo principale quello di tutelare la par condicio creditorum. Occorre inoltre segnalare che il richiesto dolo specifico consente di selezionare le condotte punibili, escludendo così quelle consistenti in più che mai leciti pagamenti finalizzati all’estinzione di alcuni debiti dell’impresa in vista di un ragionevole e presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale.
LE AGGRAVANTI SPECIALI PREVISTE DALL’ART.326 CCII
Con l’art. 326 CCII il legislatore ha previsto alcune circostanze aggravanti ed attenuanti speciali applicabili ai reati di bancarotta fraudolenta e semplice nonché al ricorso abusivo al credito ex art. 325 CCII.
Nello specifico, il primo comma prevede una circostanza aggravante speciale ad effetto speciale, ovverosia l’aumento fino alla metà delle pene stabilite dai suddetti reati, quando i fatti abbiano cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Il secondo comma stabilisce che le pene sono aumentate fino ad un 1/3 (si tratta quindi di un aggravante speciale ad effetto comune) se:
- il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli precedenti;
- il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.
Se non pone particolari problemi l’interpretazione dell’ipotesi prevista dalla lett. b), diverso è per quella di cui alla lett. a). Secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione n. 21039/2011 la stessa deve essere interpretata come una speciale norma di continuazione più favorevole rispetto alla disciplina prevista dall’art. 81 c.p., in quanto prescinde dalla sussistenza del medesimo disegno criminoso. Inoltre, la norma deve altresì essere considerata, continua la Corte, come una aggravante bilanciabile.
Infine, nell’ultimo comma è contenuta una circostanza attenuante speciale ad effetto comune in virtù della quale, nel caso in cui i fatti indicati negli articoli sopracitati abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino ad 1/3.
LA PRESCRIZIONE DEL DELITTO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Ai sensi dell’art. 157 c.p. un reato si prescrive una volta che sia trascorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto.
Nel caso della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale vuol dire che, per la prescrizione, saranno necessari 10 anni (12 anni e 6 mesi se vi sono stati atti interruttivi, come l’ordinanza di applicazione di misura cautelare o la richiesta di rinvio a giudizio etc.), mentre per la bancarotta fraudolenta preferenziale saranno sufficienti 6 anni ( 7 anni e 6 mesi in caso di atti interruttivi).
Ciò detto, preme segnalare che nel caso in cui sia contestata anche l’aggravante di cui all’art. 326 co. 1, CCII , ossia quella del danno patrimoniale di rilevante gravità, essendo la stessa un’aggravante ad effetto speciale determinerà un aumento del termine di prescrizione.
L’art. 157, co. 2 c.p. prevede infatti che “per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.”
Da ultimo occorre soffermarsi sul temine iniziale da cui decorre il tempo necessario a prescrivere il reato di bancarotta fraudolenta. In via generale l’art. 158 c.p. prevede che il termine inizi a decorrere dal momento della consumazione per i reati consumati o dal momento dell’ultimo tentativo nel caso di reato tentato. Pertanto vi è coincidenza tra il momento in cui viene posto in essere il fatto e il momento in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale. Nella bancarotta fraudolenta però occorre distinguere due ipotesi, già evidenziate in precedenza: la bancarotta pre-fallimentare e quella post-fallimentare.
Nella bancarotta pre-fallimentare il dies a quo del termine prescrizionale si individua non nel momento in cui vengono commessi i fatti, bensì nella data di emissione della sentenza di fallimento (rectius di apertura della liquidazione giudiziale). Come accennato supra, infatti, la stessa assume natura giuridica di condizione obbiettiva di punibilità ex art. 44 c.p., pertanto ai sensi dell’art. 158, co. 2 c.p. “quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.”
Al contrario, in caso di bancarotta post-fallimentare, avendo la sentenza di fallimento natura giudica di presupposto della condotta, il dies a quo del termine prescrizionale coincide con il momento in cui sono stati commessi i fatti.
BANCAROTTA FRAUDOLENTA E PATTEGGIAMENTO
Quando non è possibile dimostrare la propria non colpevolezza, una valida alternativa per mitigare la portata sanzionatoria del delitto di bancarotta fraudolenta è rappresentata dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento).
Con essa infatti, quando si riesce a concordare una pena corrispondente al minimo edittale (3 anni di reclusione), applicando la riduzione di 1/3 di pena per la scelta del rito si può ottenere una pena finale di 2 anni di reclusione, e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. potrebbe essere ancora più bassa.
In tal modo la richiesta di applicazione pena, laddove sussistano i requisiti di legge, può essere condizionata al riconoscimento della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.. Questa operazione, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., consentirebbe altresì di non subire la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione delle pene accessorie, che nel caso di bancarotta fraudolenta ai sensi dell’art. 322 co. 4 CCII sono l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 10 anni.